|
Architettura
civile e militare
Secondo
le fonti archeologiche, le prime tracce di fortificazioni
militari e di architettura civile in Sicilia risalgono alla
fine dell'epoca arcaica, vale a dire alla fine del VI sec.
a.C. Poche sono le vestigia anteriori a quel periodo benchè
sia presumibile l'esistenza di costruzioni militari già
a partire dall'VIlI sec., con l'inizio delle lotte tra le
varie città e l'ascesa dei tiranni.
Fortezze
e fortificazioni - Durante la dominazione dei tiranni
la regione si arricchisce di edifici fortificati (fine del
VI sec. a.C.), costruiti con materiali che variano a seconda
delle ricchezze geologiche del suolo: sul versante orientale
dell'isola infatti, viene comunemente usata la lava, come
lo dimostrano i siti di Naxos e Lipari. Quando le pietre
risultano insufficienti, vengono sostituite da mattoni a
crudo con cui si erigono le mura, il cui isolamento dal
terreno è assicurato da una base costituita da sassi o da
un impasto di ciottoli ed argilla.
Sebbene la Sicilia non abbia riportato alla luce numerosi
resti archeologici, sussistono tuttavia alcune fortezze.
Costruite in punti strategici nei pressi delle città o nelle
immediate vicinanze, in luoghi difficilmehte raggiungibili,
queste strutture assicurano la difesa delle città, delle
strade e di altre vie d'accesso.
Tre grandi esempi architettonici testimoniano questo tipo
di costruzione difensiva. Il Castello Eurialo, fortino eretto
alla fine del V sec. a.C. e situato a nord-ovest di Siracusa,
domina la strada principale che dalla città porta all'interno
dell'isola. Nel IV e III sec. a.C., l'edificio viene ulteriormente
fortificato con l'aggiunta di bastioni avanzati e di fossati
e guarnito di cinque massicce torri. Ad est dell'isola l'antica
città di Erice, che nel V sec. a.C. subisce una forte influenza
greca, possiede ancora i suoi bastioni la cui base poligonale
appartiene a quell'epoca. Le fortificazioni greche di Capo
Soprano, che un tempo circondano l'intera collina di Gela,
costituiscono un tipico esempio di bastioni in pietra e
mattoni.
La
città e la sua urbanizzazione - Le piante di alcune
città siciliane, tutte strutturate in base al sistema ippodamiano,
riflettono nettamente l'influenza della civiltà greca. L'urbanista
Ippodamo di Mileto, filosofo e geometra greco del V sec.
a.C., è il promotore della pianta a scacchiera adottata
nelle città greche, fondate secondo un modello costituito
da due assi: il cardo (o stenopos in greco), orientato da
nord a sud, ed il decumano maggiore (plateia in greco),
orientato da est ad ovest. La rete viaria è poi completata
da altri cardi e decumani minori che formano una maglia
ortogonale.
All'interno di questa pianta sono inseriti degli edifici
ben precisi e varie aree:
- l'agorà rappresenta, come in tutte le città greche, la
piazza principale e il centro della vita pubblica: nel periodo
classico viene cinta da portici regolari,
- il pritaneo, ai margini dell'agorà, ospita l'insieme delle
attività civiche,
- Iekklesiasterion (riservato all'ekklesia, vale a dire
l'assemblea del popolo) è un edificio pubblico profano in
cui si svolgono le riunioni popolari. Quello di Agrigento
è oggi uno dei più famosi risalenti a quel periodo. All'esterno
della pianta urbana si estendono le costruzioni religiose
e i settori a loro riservati, destinati a proteggere simbolicamente
la città.
Architettura
sacra
 L'architettura
sacra è rappresentata da due tipi di monumento: il tempio
e il teatro. Situati al di fuori delle città questi edifici
devono essere visibili da lontano, motivo per cui dominano
spesso uno splendido panorama. L'architettura
sacra è rappresentata da due tipi di monumento: il tempio
e il teatro. Situati al di fuori delle città questi edifici
devono essere visibili da lontano, motivo per cui dominano
spesso uno splendido panorama.
I
templi - A partire dall'VIlI sec. a.C. i coloni greci
importano in Sicilia i loro culti e i loro dei trasformando
l'isola in un luogo oggi considerato uno dei più straordinari
musei all'aperto di templi dorici, detti di "stile severo".
Il culto degli dei non necessita della costruzione di un
tempio, dato che quest'ultimo costituisce solo un'offerta
fatta da una o varie città e a volte da semplici privati.
Pianta
- Al centro dell'edificio si trova il naos (cella), camera
oblunga dedicata al dio. Davanti alla cella si trova il
pronaos (sorta di anticamera) mentre, nella parte posteriore,
l'opistodomos serve da camera del tesoro, completato a sua
volta (o sostituito, come nel tempio G di Selinunte) da
un adyton. Tutt'intorno si sviluppa un colonnato (peristilio).
Struttura
- Il tempio è composto da uno stilobate (basamento) su cui
poggiano le colonne, che a loro volta sostengono una trabeazione.
I lati più piccoli presentano un frontone triangolare che
permette di definire l'inclinazione del tetto a doppia falda,
ricoperto di tegole. Questa sovrapposizione di elementi
diventa rapidamente una regola di costruzione applicata
poi negli anni successivi.
Stile
- Lo stile dorico conosce il suo massimo splendore in Sicilia.
Nato nel Peloponneso, si diffonde nella Grecia continentale
e conseguentemente nei paesi colonizzati, tra cui la Sicilia,
dove esercita una forte influenza. La colonna dell'ordine
dorico, che unisce imponenza e sobrietà, possiede 20 scanalature
verticali (a partire dal V sec.) e viene innalzata senza
alcuna base, direttamente sullo stilobate. Il capitello
che la sormonta, privo di decorazioni scolpite, è formato
da un semplice cuscinetto rotondo (echino) sovrastato da
un abaco (elemento quadrato su cui poggia la trabeazione).
La trabeazione dorica è costituita da un architrave liscio,
coronato da un fregio in cui si alternano metope (pannelli
generalmente costituiti da bassorilievi scolpiti) e triglifi
(pannelli che presentano due profonde scanalature verticali
al centro e altre due più piccole ai lati).
Nel VI sec. a.C., quasi tutti i templi edificati in Sicilia
sono peripteri (vale a dire cinti da una fila di colonne)
ed esastili (la facciata comprende 6 colonne), sebbene alcuni
ne possedessero più di sei, come il tempio G di Selinunte.
Proporzioni
- Per la semplicità della sua struttura e la perfetta armonia
delle sue proporzioni, l'architettura del tempio è considerata
il prototipo della bellezza ideale. Le sue misure vengono
definite da un modulo convenzionale, calcolato in base alla
dimensione del raggio medio della colonna che influisce
maggiormente sulla struttura del monumento.
Gli architetti, constatata la tendenza dell'occhio umano
a deformare le linee degli edifici di grandi dimensioni,
pensano di arrecarvi alcune correzioni ottiche. Le trabeazioni,
la cui parte centrale sembra leggermente cedere verso il
basso, vengono rialzate in centro, acquisendo in tal modo
un'impercettibile forma arquata. Per creare un'impressione
di perfetto equilibrio, le colonne situate ai margini delle
facciate dei templi vengono inclinate verso l'interno, in
modo da evitare l'effetto contrario. Una terza correzione
viene infine apportata al fusto stesso delle colonne: nei
templi particolarmente grandi (come quelli della Concordia
ad Agrigento. di Selinunte o di Segesta) colonne perfettamente
rastremate sembrano restringersi nella parte alta, motivo
per il quale si provvede a compensare quest'illusione ottica
con un rigonfiamento (entasi) appena percettibile (e solo
a distanza ravvicinata) a circa 2/3 dell'altezza del fusto.
Decorazione
- Le sculture figurative, il cui ruolo è spesso didattico,
compaiono sugli elementi più visibili e su quelli privi
di funzione architettonica: timpano dei frontoni, metope
dell'architrave e bordo dei tetti.
I templi vengono dipinti con sfondi dei bassorilievi generalmente
rossi e parti salienti azzurre in modo da far risaltare
il candore delle sculture in marmo o in pietra. Una tonalità
"bronzo dorato" permetteva di valorizzare alcuni elementi
decorativi, quali scudi ed acroteri (motivi decorativi posti
alle estremitò o in cima al frontone). Al di sopra delle
cornici laterali (alle estremità del tetto) alcune decorazioni
scolpite, chiamate antefisse, fungono da doccioni.
 I
teatri - Nei pressi della maggior parte dei santuari
greci sorgeva un teatro dove si svolgono le feste dionisiache
(in onore di Dioniso, dio del vino), i cui inni, detti anche
"ditirambi", diedero vita alla tragedia greca. I
teatri - Nei pressi della maggior parte dei santuari
greci sorgeva un teatro dove si svolgono le feste dionisiache
(in onore di Dioniso, dio del vino), i cui inni, detti anche
"ditirambi", diedero vita alla tragedia greca.
Costruito prima in legno, poi in pietra, a partire dal IV
sec. a.C., l'edificio comprende:
- il koion o cavea, serie di gradini disposti a semicerchio
la cui prima fila è riservata ai preti e ai notabili: vi
si accede nella parte bassa attraverso entrate laterali
(parodos), nella parte centrale per una galleria (diazoma)
e in quella alta per un passaggio parallelo al diazoma;
- l'orchestra, area circolare ove, intorno all'altare di
Dionysos, prendono posto il coro e gli attori, i cui volti
sono nascosti da maschere corrispondenti al loro ruolo;
- un proscenio (proskénion) sullo sfondo, sorta di portico
che serviva da scenario, ed una scena (skéné), costruzione
dalla triplice funzione di scenario, quinte e magazzino.
Durante l'epoca ellenistica questa skéné diviene un luogo
principalmente riservato agli attori. Il muro di scena migliora
l'acustica del teatro.
Dato che questi edifici sono generalmente immersi in uno
splendido paesaggio, sul fianco di una collina o di una
montagna, lo sfondo naturale (particolarmente spettacolare
a Taormina e a Segesta) serve da scenario alle rappresentazioni.
La scena, quasi sempre sopraelevata, domina l'orchestra
circolare, ove vengono anche effettuati alcuni sacrifici.
 Attori
e spettacoli teatrali Attori
e spettacoli teatrali
Le rappresentazioni teatrali nell'antichità avevano luogo
in occasioni di feste pubbliche. Non erano quindi un evento
ricorrente o quotidiano come adesso, ma costituivano, invece,
uno dei momenti salienti di feste cittadine ed avevano,
nella maggior parte dei casi, una lunga durata (potevano
essere tre o quattro giorni di rappresentazione). Lo spettacolo
aveva luogo di giorno ed era a cielo aperto. Gli attori,
solo uomini che sostenevano anche i ruoli femminili, erano
dotati di alte calzature "i coturni" e acconciature per
essere ben visibili e di statura imponente (l'altezza era
anche indice dell'importanza sociale di un personaggio)
e indossavano maschere che permettevano di amplificare la
voce  e
di incarnare differenti personaggi (gli attori erano pochi
e sostenevano più ruoli). Esse però impedivano di sottolineare
l'azione con la mimica facciale. Proprio per questo motivo,
molto importanti erano i gesti. L'abito di scena era molto
colorato e sembra che le tinte avessero un carattere simbolico.
Così, ad esempio, il nero indicava lutto e sventura. All'identificazione
di un personaggio (età, stato sociale, stato d'animo, provenienza)
contribuivano anche la maschera e alcuni attributi a lui
comunenemente associati: la corona per ire, il bastone per
i vecchi, i copricapi per gente straniera. Oltre agli attori,
sulla scena trovava posto il coro, la cui funzione primaria
era quella di commentare gli eventi narrati. e
di incarnare differenti personaggi (gli attori erano pochi
e sostenevano più ruoli). Esse però impedivano di sottolineare
l'azione con la mimica facciale. Proprio per questo motivo,
molto importanti erano i gesti. L'abito di scena era molto
colorato e sembra che le tinte avessero un carattere simbolico.
Così, ad esempio, il nero indicava lutto e sventura. All'identificazione
di un personaggio (età, stato sociale, stato d'animo, provenienza)
contribuivano anche la maschera e alcuni attributi a lui
comunenemente associati: la corona per ire, il bastone per
i vecchi, i copricapi per gente straniera. Oltre agli attori,
sulla scena trovava posto il coro, la cui funzione primaria
era quella di commentare gli eventi narrati.
Per sottolineare la particolare drammaticità dell'azione,
o l'entrata in scena di un personaggio importante, venivano
utilizzati dei veri e propri macchinari scenici. Tra i più
noti vi sono la macchina per produrre i fulmini, un pannello
nero su cui era riprodotta, in oro zecchino, una saetta
che, mostrata all'improvviso, riluceva al sole (non si deve
dimenticare che, come già accennato prima, gli spettacoli
erano diurni), o la macchina del tuoni, in cui il rombo
era ottenuto facendo rotolare grosse pietre in un recipiente
in ottone o il Mechané, congegno tramite il quale era possibile
far apparire improvvisamente sulla scena un dio che risolvesse
la situazione. In effetti era probabilmente un gancio collegato
ad una carrucola che permetteva di far apparire, dall'alto
la divinità. L'espressione, ancora oggi utilizzata, Deus
ex Machina (usata per indicare un'improvvisa ed inaspettata
soluzione. "piombata dall'alto") deriva proprio da qui.
La
scultura
Secondo
alcuni autori greci, quali Diodoro Siculo (storico del I
sec. a.C.) e Pausania viaggiatore greco del II sec. d.C.),
la Sicilia diviene un focolaio artistico a sè stante ancor
prima di essere colonizzata. E' in ogni caso difficile individuare
uno stile siciliano prima dell'insediamento greco (VIII
sec. a.C.), a causa dei numerosi scambi artistici avvenuti
tra Sicilia e Grecia, in particolare nella parte meridionale
dell'isola in quel tempo occupata dai Sicani. Durante la
colonizzazione, la produzione artistica subisce naturalmente
l'influenza di quella greca, provocando la graduale scomparsa
dello stile puramente siciliano.
L'isola conosce quindi i tre periodi cronologici che definiscono
le correnti artistiche greche (arcaico, classico ed ellenistico).
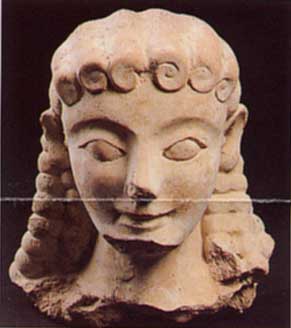 Epoca
arcaica (VIII-V sec. a.C.) - Questo periodo coincide
con la produzione delle prime statue ieratiche di grandi
dimensioni, che dà vita, nel VI sec. a.C., ai due celebri
modelli noti come kouros, figura di un giovane nudo, e koré,
raffigurazione di una giovane donna avvolta in una tunica. Epoca
arcaica (VIII-V sec. a.C.) - Questo periodo coincide
con la produzione delle prime statue ieratiche di grandi
dimensioni, che dà vita, nel VI sec. a.C., ai due celebri
modelli noti come kouros, figura di un giovane nudo, e koré,
raffigurazione di una giovane donna avvolta in una tunica.
La statua dell'Efebo di Agrigento, che costituisce un'ottima
illustrazione dello stile arcaico tardivo, dimostra una
certa ricerca estetica, sebbene l'equilibrio del corpo sia
ancora da perfezionare (la gamba destra sembra estremamente
rigida mentre le braccia tese risultano troppo lontane dai
fianchi).
Tra le decorazioni scolpite che ornano i templi, due esempi
rappresentano lo stile arcaico rinvenuto in Sicilia: la
policroma Gorgone alata, che decora il frontone dell'Athenaion
a Siracusa e le metope di Selinunte, conservate al Museo
Archeologico di Palermo. Grazie alla scoperta di sei metope
ritrovate nel muro fortificato dell'acropoli di Selinunte
e risalenti al 575 a.C., si presume che in questa città,
l'unica della regione ad aver riportato alla luce questo
tipo di decorazione, esistesse una scuola di scultura locale.
Alcune metope evocano degli dei venerati a Selinunte, come
la triade apollinea (Apollo, Artemide e la loro madre Latona)
o Demetra e Persefone. Le metope del tempio C (la Quadriga
di Apollo. Perseo e la Gorgone e Eracle ed i Cercopi), scolpite
nel calcare locale, sono ravvivate dai colori presenti su
alcuni dettagli delle loro vesti e dei loro corpi. Risalenti
presumibilmente alla metà del VI sec. a.C., queste opere
dimostrano una perfetta maestria nell'arte della composizione.
Le metope del tempio E (Hera e Zeus, Eracle che lotta con
un'Amazzone) costituiscono veri e propri capolavori, spesso
paragonati alla decorazione del Tempio di Zeus ad Olimpia.
Epoca
classica (V-III sec. a.C.) - Quest'epoca, caratterizzata
da una maggiore morbidezza nell'arte statuaria, si libera
dell'antico aspetto rigido e severo.
L'Efebo di Mozia, in marmo bianco, riportato alla luce senza
braccia nè piedi e è oggi conservato sul luogo del ritrovamento
nel Museo Giuseppe Whithaker, testimonia tale evoluzione:
questo giovane, alto 1.81 m, le cui morbide forme rivelano
il tipico stile del V sec., indossa una lunga tunica di
soffice e avvolgente lino che evidenzia il suo muscoloso
corpo d'atleta. Sembra che questo marmo, unico in Sicilia,
sia stato importato allo stato grezzo dall'Anatolia e poi
lavorato sul posto. L'identificazione di quest'efebo ha
sollevato numerose ipotesi ma gli studiosi non sono ancora
giunti ad una conclusione definitiva.
Gli atlanti (o telamoni) del Tempio di Zeus Olimpio Agrigento,
un tempo addossati ai muri che si ergono tra le colonne,
appaiono estremamente imponenti per via delle loro dimensioni.
Il Museo Archeologico Regionale di Agrigento ne conserva
attualmente un solo esempio (alto 7,75 m).
Alcuni motivi decorativi dei templi, come le antefisse a
forma di testa di leone (Museo Archeologico di Palermo),
confermano la maggiore abilità acquisita dagli artisti durante
il periodo classico.
Epoca
ellenistica (III-I sec. a.C.) - In questi secoli, l'arte
scultorea inizia a tendere verso l'espressionimo e l'orientalismo
e conferisce alle divinità scolpite un aspetto più spoglio
(ad esempio Afrodite, dea della bellezza e dell'amore, indossa
una tunica plissettata e fluida che, lascia scoperta una
parte del suo corpo) e dei tratti più umani. Questo periodo
esprime, con un realismo a volte esasperato, non solo emozioni
ma anche vari movimenti quali la forza e la danza.
La scoperta dell'ariete bronzeo a Castello Maniace, dimostra
che Siracusa è la città in cui l'influenza dei canoni greci
dell'epoca ellenistica si fa maggiormente sentire. In origine
questo capolavoro risalente al III sec. a.C., faceva parte
di una coppia che orna il palazzo dei tiranni della città
(eretto sull'antica isola di Ortigia). Il prezioso animale,
mai eguagliato nella precisione dei tratti e nell'esecuzione,
costituisce oggi uno dei pezzi più pregiati del Museo Archeologico
di Palermo.
Le maschere teatrali in terracotta del Museo Archeologico
di Lipari (più di 250 modelli) risultano di notevole interesse
per le varie emozioni che esprimono, tutte influenzate dalla
tragedia greca che si diffonde in Sicilia nel III sec. a.C.
Pittura
e ceramica
La
pittura è considerata dai Greci l'espressione artistica
più nobile ed eloquente, definita dal poeta greco Simonide
(V sec. a.C.) "poesia muta". Le testimonianze di quest'arte
sono purtroppo rare, data l'estrema sensibilità dei pigmenti
delle tinture, poco resistenti al tempo. Gli unici esempi
di arte grafica greca provengono quindi dai vasi.
Le
forme - I pithos vengono utilizzati per la conservazione
delle granaglie, mentre la doppia funzione delle anfore
è quella di conservare e trasportare olio e vino. Le pelike,
i crateri e le idrie servono rispettivamente da giare per
l'olio, per il vino e per l'acqua. Sono inoltre molto comuni
le oinochoe, brocche per contenere l'acqua o il vino versato
in seguito nei cantari, le kylix (coppe da cui si beve)
ed i rhython, recipienti a forma di corno o di testa di
animale. I lekythos sono invece vasi funerari.
Gli
stili - I vasi a figure nere su sfondo rosso o giallo
risalgono all'epoca arcaica e all'inizio dell'epoca classica.
I dettagli delle figure vengono ottenuti incidendo semplicemente
la vernice nera con una punta d'acciaio. Le scene più ricorrenti
sono generalmente legate alla mitologia e alla vita quotidiana,
benchè presentino a volte solo figure astratte (motivi decorativi
dei vasi più antichi).
I vasi a figure rosse appaiono in Italia meridionale verso
la fine del V sec. a.C., in anticipo rispetto alla Grecia
dove questo stile si diffonde solo nel 480 a.C. La vernice
nera, impiegata negli altri vasi per disegnare le figure,
serve ormai unicamente da sfondo alle decorazioni che mantengono
invece il colore rosso dell'argilla. Quest'inversione, che
concede una maggiore libertà di movimento, costituisce una
scoperta rivoluzionaria per gli artisti, i cui disegni acquisiscono
tratti più morbidi di quelli incisi con una punta. I temi
raffigurati non subiscono invece notevoli variazioni. Tra
gli esempi più belli di vasi attici d'importazione, figurano
i magnifici crateri a volute di Agrigento (V sec. a.C.).
|
 L'architettura
sacra è rappresentata da due tipi di monumento: il tempio
e il teatro. Situati al di fuori delle città questi edifici
devono essere visibili da lontano, motivo per cui dominano
spesso uno splendido panorama.
L'architettura
sacra è rappresentata da due tipi di monumento: il tempio
e il teatro. Situati al di fuori delle città questi edifici
devono essere visibili da lontano, motivo per cui dominano
spesso uno splendido panorama.  I
teatri - Nei pressi della maggior parte dei santuari
greci sorgeva un teatro dove si svolgono le feste dionisiache
(in onore di Dioniso, dio del vino), i cui inni, detti anche
"ditirambi", diedero vita alla tragedia greca.
I
teatri - Nei pressi della maggior parte dei santuari
greci sorgeva un teatro dove si svolgono le feste dionisiache
(in onore di Dioniso, dio del vino), i cui inni, detti anche
"ditirambi", diedero vita alla tragedia greca.  Attori
e spettacoli teatrali
Attori
e spettacoli teatrali  e
di incarnare differenti personaggi (gli attori erano pochi
e sostenevano più ruoli). Esse però impedivano di sottolineare
l'azione con la mimica facciale. Proprio per questo motivo,
molto importanti erano i gesti. L'abito di scena era molto
colorato e sembra che le tinte avessero un carattere simbolico.
Così, ad esempio, il nero indicava lutto e sventura. All'identificazione
di un personaggio (età, stato sociale, stato d'animo, provenienza)
contribuivano anche la maschera e alcuni attributi a lui
comunenemente associati: la corona per ire, il bastone per
i vecchi, i copricapi per gente straniera. Oltre agli attori,
sulla scena trovava posto il coro, la cui funzione primaria
era quella di commentare gli eventi narrati.
e
di incarnare differenti personaggi (gli attori erano pochi
e sostenevano più ruoli). Esse però impedivano di sottolineare
l'azione con la mimica facciale. Proprio per questo motivo,
molto importanti erano i gesti. L'abito di scena era molto
colorato e sembra che le tinte avessero un carattere simbolico.
Così, ad esempio, il nero indicava lutto e sventura. All'identificazione
di un personaggio (età, stato sociale, stato d'animo, provenienza)
contribuivano anche la maschera e alcuni attributi a lui
comunenemente associati: la corona per ire, il bastone per
i vecchi, i copricapi per gente straniera. Oltre agli attori,
sulla scena trovava posto il coro, la cui funzione primaria
era quella di commentare gli eventi narrati. 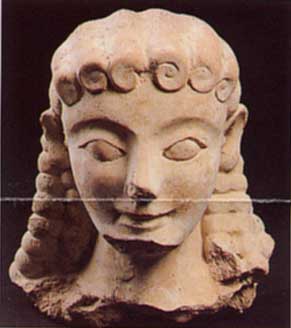 Epoca
arcaica (VIII-V sec. a.C.) - Questo periodo coincide
con la produzione delle prime statue ieratiche di grandi
dimensioni, che dà vita, nel VI sec. a.C., ai due celebri
modelli noti come kouros, figura di un giovane nudo, e koré,
raffigurazione di una giovane donna avvolta in una tunica.
Epoca
arcaica (VIII-V sec. a.C.) - Questo periodo coincide
con la produzione delle prime statue ieratiche di grandi
dimensioni, che dà vita, nel VI sec. a.C., ai due celebri
modelli noti come kouros, figura di un giovane nudo, e koré,
raffigurazione di una giovane donna avvolta in una tunica.

